La svolta elettrica di Dylan - The Cutting Edge
The Cutting Edge: La svolta elettrica di Bob Dylan (1965-1966).
Senza nulla togliere a quello che è venuto dopo, ma è innegabile il fatto che per Bob Dylan il decennio d’oro sia quello rappresentato dal periodo 1962-1971. Basta prendere tra le mani il cd o il vinile di "More Bob Dylan Greatest Hits" per rendersi conto di questo fatto. Entrando più nello specifico il decennio è stato caratterizzato da un flusso creativo senza alcun precedente, di cui “The Cutting Edge” rappresenta l’apogeo. The Bootleg Series Vol. 12: The Cutting Edge 1965-1966 è il dodicesimo volume (in realtà decimo) dedicato al materiale d’archivio, di studio e dal vivo del catalogo dylaniano, pubblicato nel novembre 2015. Si tratta di una raccolta formidabile che per la prima volta unisce i tre capolavori della cosiddetta svolta elettrica, comprendente gli album Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited e Blonde on Blonde.
La critica
dylaniana oggi può essere suddivisa in tre macro-categorie. La prima categoria
include i decani come Greil Marcus, Paul Williams e in generale tutti quegli
autori che hanno assistito alle varie epoche sonore di Dylan. Leggendo questi
critici sarà evidente il loro approccio legato principalmente alla figura del
giovane menestrello che partendo come emulo di Woody Guthrie, riesce a farsi
strada prima negli ambienti folk newyorkesi e poi sotto contratto con la
Columbia Records conquistando prima il pubblico nordamericano e poi piano piano
quello della canzone d’autore mondiale e universale. Per Marcus però ci sarà
sempre un giovane artista armato di chitarra acustica e armonica dietro ogni
registrazione e composizione futura. Non è per forza di cose un aspetto
negativo, ma in una certa misura è una limitazione, così come il fatto di
partire dal suo vasto background culturale e musicale, che gli impone di
criticare i successi che arriveranno dopo la seconda metà degli anni Settanta.
Marcus non a caso non accetta di buon grado il ripescaggio delle sonorità
“pre-rock and roll” di “Love and Theft”. Lo stesso atteggiamento sarà adottato
da Riccardo Bertoncelli e soprattutto da Cesare Rizzi, che nel suo Atlante
Giunti, stronca senza riserve il disco pubblicato nel 2001.
Ci sono però ad oggi altri critici, che non hanno seguito l’intera carriera e l’evoluzione dylaniana dei primi anni sessanta. Mi è capitato più volte di confrontarmi con appassionati di musica che non conoscono affatto la svolta elettrica, di altri che amano la produzione anni settanta del cantautore, di ascoltatori distratti che conoscono alcune cose, ma ne ignorano il resto. Oggi molto spesso chi scrive su riviste, siti musicali e pubblica anche saggi su cartaceo non ha assistito nemmeno alla svolta religiosa avvenuta con Slow Train Coming e Saved (e in modo minore con Shot of Love). Qualcuno ha fatto in tempo a vedere in tempo reale Bob Dylan esibirsi a Bologna davanti a Giovanni Paolo II, nel 1997. Arriviamo infine a quella generazione che si è accostata a Dylan durante gli ultimi quindici-diciotto anni. In quel caso la loro comprensione di epoche storiche e fasi musicali è condizionata da un ascolto spesso bulimico e confuso, effettuato attraverso piattaforme come Spotify, discografie scaricate in mp3 o peggio ancora tramite YouTube. Eppure oggi anche un decano della canzone come Dylan deve fare i conti con questo tipo di pubblico. Ed è un pubblico che potenzialmente può acquistare anche la musica del passato e farla propria. In questo caso però ci sarà tutto il catalogo a disposizione, ma un artista ormai avanti con gli anni che in tempo reale ha pubblicato quattro lavori autografi e quattro album composti esclusivamente da cover e reinterpretazione di materiale altrui. Iniziando ad ascoltare Dylan a partire dal 2006-2007, questo pubblico si sarà presto confrontato anche con le molte uscite antologiche, a partire dal bellissimo Tell Tale Signs: Rare and Unreleased 1989-2006, che raccoglie molte cose già edite e alcune nuove che Dylan ha composto in quell’arco temporale.
Nello stesso periodo l’autore ha
rilasciato altri prodotti multimediali, come film, documentari e la sua
splendida autobiografia, Chronicles Volume One. Intanto le raccolte proseguono
con i volumi 9-10 e 11 che coprono diversi periodi storici, dal 1962 con The
Witmark Demos, passando per gli anni di Nashville Skyline, Self Portrait e New
Morning (volume 10) fino ad arrivare al volume 11 dedicato ai leggendari Basement
Tapes, le sessioni del 1967 con The Band. La compilation descrive e fotografa
una nuova evoluzione musicale e sonora di Dylan, quella che su disco ufficiale
possiamo ascoltare attraverso John Wesley Harding e Nashville Skyline e che ci
riconduce all’incipit di questo post: il Greatest Hits Vol. II pubblicato da
Columbia nel 1971. La versione più conosciuta di questa raccolta è composta da
due dischi per 21 tracce, ma a differenza di tante altre compilation, qui
trovano spazio un numero elevato di brani inediti, molti dei quali appartengono
proprio al periodo di Basement Tapes (1967-1968).
Pubblicato il 6 novembre 2015, a cavallo tra Fallen Angels e Shadows in the Night (due dei tre dischi dedicati al Great American Songbook) questo volume unisce ed esplora il periodo in cui Dylan registra la sua trilogia elettrica. Tutto avviene piuttosto velocemente, rispetto a come vengono registrati oggi (ma anche negli anni ’70 e ‘80) i dischi. La prima registrazione risale infatti al gennaio 1965, mentre l’ultima chiude le sessioni nel maggio 1966. Tanto bastò a Dylan e ai musicisti che parteciparono agli album per scrivere il suo nome all’interno del folk-rock. Senza entrare nella solita diatriba su chi abbia iniziato cosa, quale sia stato il primo disco a essere pubblicato, in questi 16 mesi il cantautore pubblica un numero sensazionale di brani che verranno tramandati ai posteri, fino ad arrivare ad oggi con una grande carica dirompente e una forza poetica che ancora oggi non contempla paragoni di sorta. Dobbiamo pensare che all’epoca a parte Beatles e poche altre eccezioni, la musica che veniva prodotta era poco più che artigianato e materiale usa e getta, come certo pop anni Novanta, per intenderci. Tuttavia la musica popolare era un genere che vendeva bene e c’erano interessi economici per fare progredire e avanzare l’industria musicale.
Il merito in questo caso fu anche di persone come Tom Wilson, Bob Johnston e soprattutto come il leggendario talent scout John Hammond. Una personalità di spicco che solo per rimanere in ambito musicale (ma ebbe meriti anche a livello sociale e politico, viste le sue scelte artistiche) aveva scoperto Billie Holiday, Aretha Franklin, Pete Seeger e più avanti avrebbe messo sotto contratto anche Leonard Cohen e Bruce Springsteen. Considerato negli ambienti come “il più grande music man di tutti i tempi” fu merito di Hammond se Dylan ebbe un contratto e la libertà di esprimersi, nonostante le prime pubblicazioni non ebbero un grande impatto e un successo commerciale adeguato. Nel 1965 però quando Dylan entrava in studio per comporre quello che sarebbe stato il suo primo disco elettro-acustico, le cose erano già cambiate in favore dell’autore e della CBS stessa. Hammond era stato elogiato per aver scoperto ancora una volta un artista che sarebbe durato nel tempo e che, fatto più importante, avrebbe fatto vendere un bel numero di lp all’etichetta.
Nessuno però immaginava quello che sarebbe successo di lì a poco. Così se Bringing It All Back Home è ancora suddiviso in due facciate, una elettrica (ma con arrangiamenti e suoni ancora canonici) e una acustica di maggior spessore, per quanto riguarda le sue composizioni, quello che accadde con il sequel, Highway 61 Revisited ha qualcosa di sensazionale e di leggendario per la storia della musica pop statunitense e non solo. Nei solchi di questo album trovano spazio composizioni come Desolation Row, Ballad of a Thin Man, Tombstone Blues, la stessa title track, ma soprattutto un pezzo epocale come l’iniziale Like a Rolling Stone, canzone che oggi fortunatamente non ha bisogno di presentazione.
Un nucleo di musicisti capitanati da Mike Bloomfield alla chitarra, Paul Griffin al piano, Harvey Brooks al basso e Bobby Gregg alla batteria, conduce il gioco, ma è l’apporto di Al Kooper all’organo a dare quel tocco in più all’album, con quel peculiare stile gospel che resterà per sempre legato al periodo e alle registrazioni di questo capolavoro. Lo step successivo, realizzato stavolta nel 1966 (Bringing it All Back Home e Highway 61 Revisited hanno anche il merito di essere stati prodotti e registrati nello stesso anno e a distanza di pochi mesi) si chiama Blonde on Blonde e avrà una gestazione più lunga, coinvolgendo un numero elevato di musicisti, ma che verrà registrato e sviluppato per 3/4 della sua durata negli studi Columbia di Nashville.
Un’intuizione che per come vengono raccontate le cose sul libro di Daryl Sanders “Un sottile, selvaggio suono mercuriale” (Bob Dylan, Nashville e Blonde on Blonde) è farina del sacco di Bob Johnston, che aveva contro una buona parte dell’etichetta. Dylan e Johnston la spuntarono e portarono con loro anche il chitarrista degli Hawks (poi The Band) Robbie Robertson e il nuovo entrato Al Kooper, che con il suo suono di organo contribuirà anche stavolta alla buona riuscita del doppio album. Blonde on Blonde è storia, oggi, proprio come i due prequel di cui abbiamo scritto sopra, ma l’atteggiamento sospetto sulla svolta elettrica (in realtà ci sono suoni acustici ben definiti in tutti gli album) di Dylan ancora oggi a distanza di anni permane per molta della critica militante affezionata a quell’epoca storica.
Dipende da come e cosa si vuole ascoltare. In attesa che il
cantautore americano pubblichi un nuovo album capace di farci drizzare le
antenne e di spiazzarci ancora una volta. Lo ha sempre fatto nel corso di una
carriera che dura ormai da 60 anni.
Dario Greco




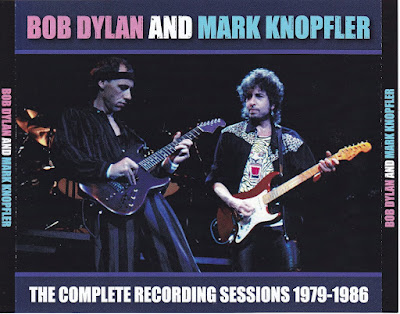


Commenti
Posta un commento